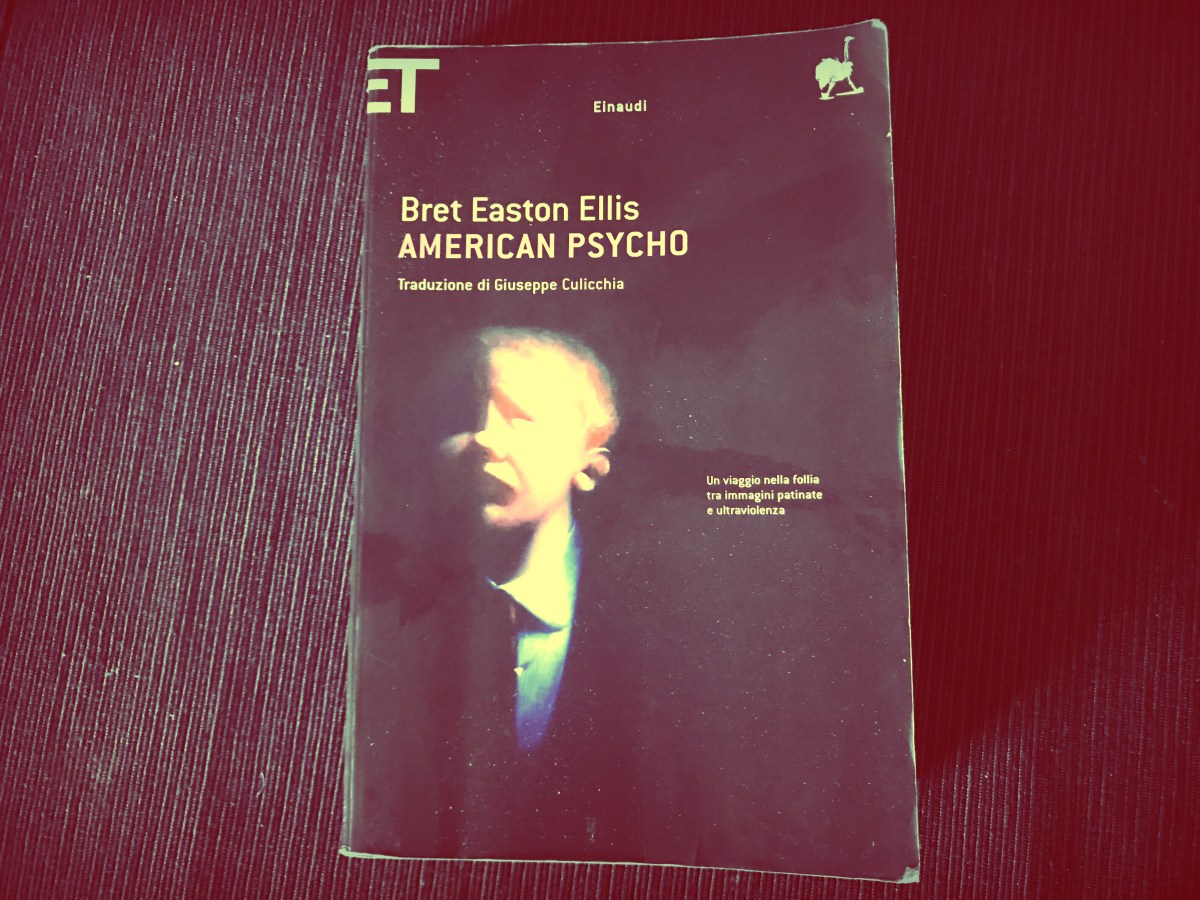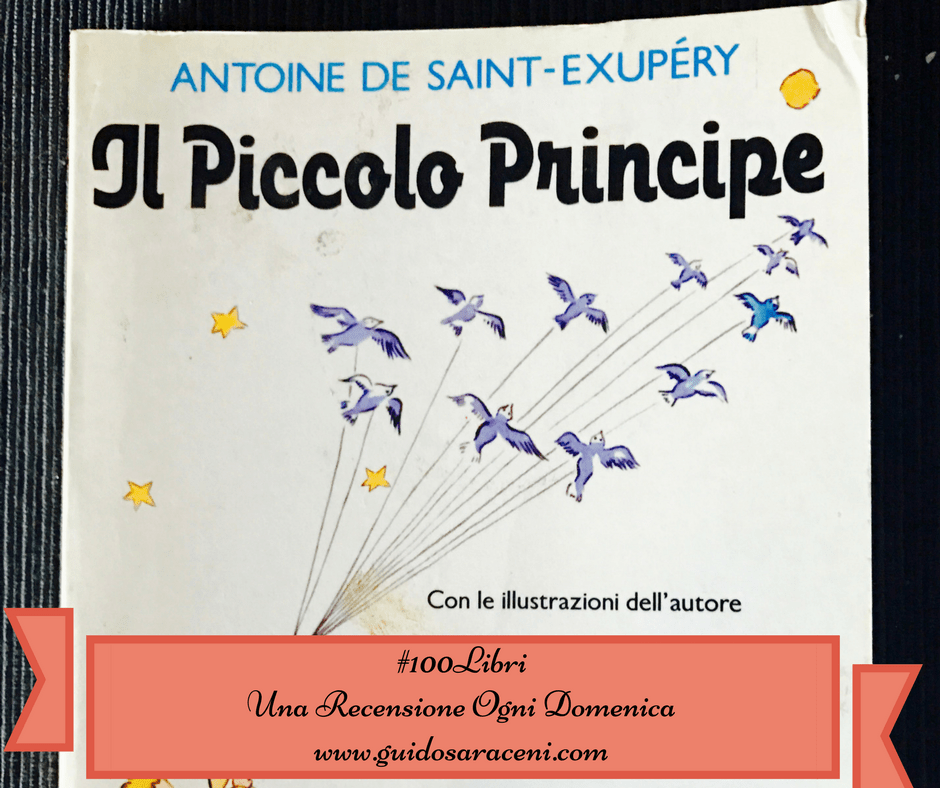Dylan Dog, mensile, Sergio Bonelli Editore.
Dellamorte Dellamore, Tiziano Sclavi, Cammina, Milano 1991, 167 pp., L. 22.000.
Una delle cose più belle che possono fare per te i tuoi amici è di farti conoscere un film, un disco, un romanzo. Mi fa sempre piacere ricordare cosa mi hanno consigliato, e, se sono stati consigli azzeccati, resto loro per sempre grato. Ad esempio, so bene che Dylan Dog lo devo a Flavio. Un giorno, nel lontano 1989, mi disse che avrei assolutamente dovuto leggerne un numero, e siccome io ero parecchio scettico – ero convinto che non mi sarebbe in alcun modo piaciuto o interessato – mi prestò tre o quattro albi, obbligandomi a leggerli. Fino ad allora, avevo letto Topolino, Lupo Alberto, le strisce di Bonvi, le vignette di Forattini, Alan Ford e Linus. Da quel giorno, Dyd divenne il mio unico eroe e punto di riferimento. Assieme a me, un’intera generazione si appassionò all’Indagatore dell’incubo, tanto che la tiratura raggiunse in pochi numeri le 150.000 mila copie battendo molti altri record. Dyd divenne presto uno dei fumetti più venduti in Italia, vendendo anche più copie del celeberrimo Tex.
Insomma, Dyd divenne un fenomeno di costume, un eroe conosciuto e venerato da moltissimi piccoli e grandi lettori – al pari dei più celebri e antichi supereroi americani. Questo straordinario successo dipese da una serie di fattori vincenti e difficilmente replicabili. Prima di tutto, il fascino del protagonista: un ragazzo sulla trentina tormentato dai suoi incubi che lotta contro fantasmi, licantropi, vampiri e mostri di vario genere e natura – provando, così, a risolvere gli incubi degli altri. Dylan è un ex poliziotto, ex alcolista, un uomo dal passato torbido e oscuro, un amante della musica heavy metal e della musica classica, un suonatore di clarinetto in grado di suonare un solo brano per ore – il trillo del diavolo – un appassionato di modellismo, da sempre impegnato a costruire il suo infinito galeone, un personaggio colmo di fissazioni, di tic e di nevrosi – ipocondriaco, vegetariano, soffre di vertigini e di mal di mare – che sembra non essere mai uscito dall’adolescenza, perché della adolescenza ha mantenuto intatte le ingenuità e gli inflessibili princìpi. In secondo luogo, la simpatia dei co-protagonisti: il fedele amico, “maggiordomo” e assistente Groucho – liberamente ispirato a un membro dei fratelli Marx, gruppo comico tra più famosi degli anni ’20 – il personaggio che “alleggerisce” l’atmosfera delle avventure di Dyd con le sue battute, il deus ex machina di tante storie, sempre pronto a lanciare la pistola al capo nei momenti di maggiore difficoltà e l’altrettanto mitico Bloch – la figura paterna di un eroe senza genitori, l’ispettore di polizia calvo e in sovrappeso, eternamente sull’orlo della pensione, che prova, quando possibile, a far ragionare il suo migliore amico. Piccola curiosità: accanto a Dylan ci sono due personaggi il cui nome rimanda ad altrettanti filosofi comunisti (Groucho Marx – Ernst Bloch). Infine, la Fata Morgana, la donna perfetta – la madre – che il protagonista sembra cercare invano negli occhi delle sue molteplici fidanzate e amanti.
Oltre alla complessità psicologica dei personaggi, davvero poco comune per un fumetto, il grande successo di Dyd è certamente dipeso dalla qualità dei disegni. Una delle cose che mi sorprese era che non esisteva un solo Dylan Dog, non esisteva un solo modo di immaginare e disegnare i personaggi – che restavano comunque riconoscibili – perché i disegnatori cambiavano ogni mese e le differenze erano davvero notevoli. Al punto che ciascuno di noi aveva i suoi disegnatori preferiti. Io, ad esempio, amavo le inimitabili tavole di Corrado Roi e quando decisi di disfarmi della mia collezione – ebbene sì, l’ho fatto – misi da parte solo gli album che aveva firmato questo indiscutibile e geniale artista della china.
Ho smesso di leggere Dyd perché le storie iniziavano ad annoiarmi. Alla fine della fiera, lo scienziato, il ricco e il borghese erano sempre cattivi, mentre “i diversi” – di ogni genere e specie – erano quasi sempre buoni, ma discriminati dalla società ipocrita e perbenista; il meccanismo retorico dei “mostri buoni” , le metafore psicologiche, i rizomi e i dilemmi filosofici si assomigliavano un po’ troppo e iniziavano a darmi a noia. Mi congedai quindi dal mio eroe, convinto che non avrei mai letto un altro fumetto così ben scritto e disegnato fino al giorno in cui non mi imbattei nell’ultima annata di John Doe – ma questa è un’altra storia di cui magari parleremo un giorno. Tornando a Dyd, mi rendo conto che questo non è un romanzo, ma ho pensato che fosse giusto inserirlo nei miei #100 libri perché si tratta di uno dei fumetti più venduti in Italia, perché viene tradotto e venduto all’estero, perché ne hanno tratto qualche videogame e due film e soprattutto perché il suo antenato è Della Morte dell’Amore – il romanzo di Tiziano Sclavi, primo ideatore e vero padre di Dyd – che gli appassionati del fumetto non possono lasciarsi sfuggire.
Voto: 9.
Se non l’avete mai letto, fatevi un regalo, andate in edicola e compratene quattro o cinque numeri a caso, ne resterete affascinati.